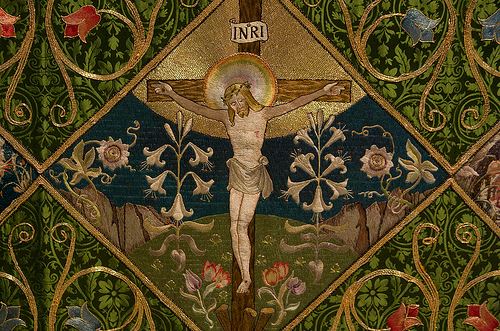Fare esperienza della propria impotenza è quanto di più salutare possiamo augurarci nella nostra ricerca della felicità.
Ci sono giorni più degli altri in cui sentiamo un grande peso sul cuore. Sono i giorni in cui avvertiamo maggiormente la distanza tra il quotidiano e il desiderio di andare oltre, tra quello che stiamo facendo in quell’istante e il luogo in cui vorremmo essere. Ci sono poi i momenti in cui avvertiamo di essere un peso anche per noi stessi, e avremmo voluto non dire quella frase e non cedere alla legge dell’impulso, non soccombere sotto la scure dell’ira o della rabbia. E infine c’è il tempo della delusione, dove ti sembra che hai faticato invano, dove ogni sforzo è cancellato dal rifiuto degli altri, dove il peso del giudizio ci schiaccia fino a convincerci che forse “vali davvero poco”.
È il tempo in cui prendiamo coscienza dei nostri limiti, delle nostre imperfezioni e così viviamo lo scandalo di essere uomini soggetti alla finitudine. La cultura di oggi però non ammette sconti: non puoi non essere perfetto, non puoi non essere forte. E così inseguiamo sogni che ci parlano solo di luce e che non tengono conto delle tenebre, del dolore e della sofferenza. E lottiamo per avere quella luce frutto di tecniche che nutrono solo il sensazionalismo e il sincretismo. E mentre siamo impegnati a inseguire le nostre fragilità per abbatterle e cancellarle, la vita scorre via lasciandoci la sensazione di combattere contro i mulini a vento.
Sono questi i momenti in cui il male può insinuarsi nella nostra vita. Concentrati sull’evitare la sofferenza e il dolore, diventiamo vittime del compromesso e della bugia. Pur di non ammettere i nostri limiti siamo pronti a piegarci al signore di turno. Ci illudiamo che quella luce artificiale, quel trucco, quella posizione lavorativa, quella tecnica orientale di rilassamento sia in grado di nascondere le nostre imperfezioni. Anche nelle relazioni, quando la lotta diventa più dura e si tratta di soffrire per l’altro, si preferisce fuggire via perché non siamo pronti ad accogliere i nostri limiti, figuriamoci quelli degli altri.
Non è stato così per Teresa di Gesù Bambino. Proprio riconoscendo la sua impotenza, si è aperta ad un vuoto che solo Dio poteva colmare. Così scrive nel suo Manoscritto: “Signore, so che non comandate niente di impossibile, voi conoscete meglio di me la mia debolezza, la mia imperfezione, sapete bene che non potrei mai amare le mie sorelle come le amate voi, se voi stesso, o mio Gesù, non le amate in me” (Ms C, 261). La forza di Teresa sta nell’arrendersi, nell’accogliere le sue debolezze come il luogo dove Dio rivela il suo assoluto primato. Non fugge davanti alla sofferenza. Non rifiuta lo scandalo dei suoi limiti.
E se provassimo anche noi a fare come Teresa? Se ci sentissimo così poveri da non desiderare altro che di essere amati per la nostra pochezza e debolezza? Teresa ha compreso che quanto più l’uomo accetta la sua imperfezione tanto più può accogliere l’amore incondizionato di Dio nel suo cuore. Teresa si sente amata.
Quella di sentirsi amati è una delle esperienze più significative del nostro percorso verso la felicità. E allo stesso tempo la ferita più dolorosa accanto al non sentirsi amati, è il ritenersi indegni di amore. In un libro molto bello sull’argomento che ho letto nella mia gioventù ma che in questi giorni ho rispolverato, Henri J. M. Nouwen, psicoterapeuta e sacerdote, scrive che tutta la nostra vita è contrassegnata da una lotta contro le voci interiori che ci dicono – ora sommessamente, ora gridando – che non siamo abbastanza bravi, intelligenti o attraenti, che non siamo abbastanza spirituali e degni di amore. “Nel corso degli anni sono giunto a capire che la più grande trappola della nostra vita non è il successo, la popolarità o il potere, ma il rifiuto di sé” (Sentirsi amati, Queriniana, Brescia, 1992) e aggiunge che la trappola del rifiuto di sé e della convinzione di non poter essere amati per noi stessi, non è di natura tale che gli esseri umani la possano vincere con le loro sole forze. Solo Gesù per Nouwen può guarire le nostre ferite. Solo da Lui ci si può sentire amati totalmente.
È l’esperienza che faccio quando vivo l’adorazione eucaristica. Non è così anche per voi? Non capita anche a voi che in quel tempo, faccia a faccia con l’Eterno, quando non riuscite a formulare una frase di senso compiuto, comprendete in un attimo che l’unica cosa che conta è essere lì, guardata, amata e illuminata da Colui che vi conosce fin nelle profondità, che non vi fa vibrare di vergogna per i vostri peccati o le vostre mancanze ma vi dona il calore della sua misericordia infinita?
Il 17 settembre 1896, un anno prima di morire, scrivendo alla sorella suor Maria del Sacro Cuore, santa Teresa scrive: “Ciò che piace a lui [Dio] è di vedermi amare la mia piccolezza e la mia povertà … più si è deboli, senza desideri né virtù, più si è adatti alle operazioni di questo Amore che consuma e trasforma!”.
Teresa, come anche altri santi – che faremmo bene a frequentare perché sono dei maestri di felicità – ci insegna che accogliere le proprie imperfezioni non significa di certo vivere una vita mediocre e ripiegata ma lasciare che la grazia di Dio operi nella nostra vita. Amare con il cuore di Dio.
Tutto questo non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio ma anche dell’amicizia sincera delle persone che amiamo. E dobbiamo lasciare loro lo spazio per poter entrare, guardare le nostre fragilità come si guarda quel seme che si squarcia immaginando già il frutto. Sono queste persone che continuano a credere in noi, ad amarci nonostante abbiamo smesso di investire sui nostri talenti. E lo fanno con quella pazienza e quella perseveranza che mentre annulla la pretesa di poter fare da soli, ci restituisce la bellezza della nostra fragilità.
Giovanna Abbagnara
24 ottobre 2017